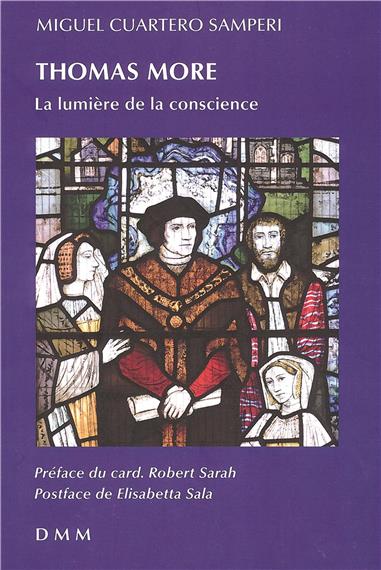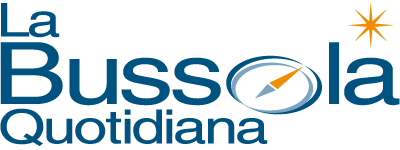San Tommaso Moro comico ed umorista? Un grande equivoco.

Tommaso Moro non è “morto dal ridere” ma è stato ucciso in odio alla fede per aver difeso Dio e la Chiesa. È stato recentemente presentato come esempio per i comici di tutto il mondo, ma il martire inglese insegna molto di più che l’arte di “far ridere”. [Una sintesi di questo articolo è stata pubblicata su La Nuova Bussola Quotidiana]
Il 22 giugno la Chiesa ha ricordato i martiri inglesi Tommaso Moro, gran cancelliere del Regno d’Inghilterra, e John Fisher, vescovo di Rochester. Entrambi persero la vita per mano del re Enrico VIII a causa del loro rifiuto di firmare l’atto di Supremazia che sentenziava la separazione del Regno dalla Chiesa di Roma e l’insubordinazione al Papa.
Tommaso Moro è stato recentemente, e più volte, citato nel contesto di un incontro avvenuto in Vaticano il 14 giugno tra papa Francesco e una delegazione di comici provenienti da tutto il mondo, in particolare dall’Italia. Un incontro organizzato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione guidato dal card. José Tolentino de Mendonça con l’aiuto del sacerdote gesuita Antonio Spadaro, presenti, tra gli altri, all’incontro.
Rivolgendosi a questa anomala delegazione nella Sala Clementina il Papa ha confidato che da più di 40 anni prega di prendere la vita con sana ironia recitando le parole attribuite a san Tommaso Moro: “Dammi, Signore, il senso dell’umorismo”.
Francesco ha invitato gli artisti a conoscere questa preghiera incaricando “i superiori” a distribuirla. Al termine dell’incontro la comica italiana Luciana Littizzetto ha solennemente letto la preghiera “Del buon umore” a tutti i presenti che hanno risposto con un grande applauso.
In effetti uno dei motivi per cui il santo inglese è comunemente ricordato – assieme alla composizione di Utopia e alla vicenda del suo martirio – è il suo carattere allegro e la sua proverbiale ironia di cui danno conto le numerose testimonianze di chi lo ha conosciuto, le sue lettere e i suoi epigrammi.
Esperto nell’arte del governo e nell’esercizio del potere come servizio, Moro governò la sua casa con sapienza tanto da portare l’amico Erasmo a definire la sua famiglia una sorta di “accademia platonica fondata su basi cristiane”.
La sua casa rispecchiava gli ideali moreani di convivenza umana dove si coltivavano le più alte virtù, l’arte, l’educazione, il reciproco rispetto. Il tutto condito da una vena di allegria e spensieratezza affinché le regole interne non appesantissero gli animi dei componenti della famiglia e dei numerosi ospiti che trovavano accoglienza in famiglia.
Fu così alta la considerazione dell’umorismo e della comicità che Moro volle assumere nella propria casa un buffone incaricato di intrattenere la famiglia specie durante i suoi periodi di assenza. Di sir. Henry Patterson, che compare nel noto ritratto familiare composto da Hans Holbein, si dice che avesse un bel da fare “per non apparire troppo meno spiritoso del suo padrone, ma che alla fine se la cavava discretamente” (G. Gangale, Una grande casa. Il primato di Dio nella vita e nella famiglia di san Tommaso Moro, Grafite 2001).
Tuttavia nel sottolineare un solo aspetto della figura di Tommaso Moro rischiando di ricordarlo solo ed esclusivamente per la sua allegria e la sua sagacia, si insinua un terribile equivoco: quello di considerarlo un semplice buffone, un facilone e un ingenuo pagliaccio dai buoni sentimenti da presentare al mondo per indicare la via del riso e dell’ironia. In realtà è necessario ricordare un dato basilare: nel 2000 Tommaso Moro è stato proclamato da san Giovanni Paolo II patrono dei governanti e politici, non certo patrono dei comici e degli umoristi.
Non è infatti la sua ironia a fare di lui un santo ma il suo vivere sempre ed in ogni situazione, fin dall’inizio della sua carriera, illuminato dalla luce della fede con una coscienza retta e una coerenza che lo ha portato fino al martirio, ossia alla vita donata per la difesa della fede. Dal periodo giovanile di formazione, la sua difficile e travagliata scelta vocazionale, il suo matrimonio, la vedovanza e il secondo matrimonio, l’impegno come giudice nella City e la sua carriera politica alla Corte di Enrico VIII e infine il suo epilogo segnato dal completo isolamento e dal tradimento di chi gli fu amico e confidente.
Fare di Tommaso Moro un buffone non fa onore ad un uomo che in ogni momento ebbe, sì, la battuta pronta – segno di una capacità di affrontare i problemi con la giusta dose di leggerezza – ma che diede prova di una profondità e di una serietà senza uguali al momento di prendere decisioni importanti per la sua vita. Ultima delle quali quella di voltare le spalle al suo Re per seguire la sua coscienza, decisione che comportava gravissime conseguenze non solo per la sua persona, ma per tutti i suoi cari.
È vero che Moro diede prova di grande umorismo e comicità, specie nei suoi Epigrammi, quando ad esempio scherzando sulle donne scriveva che «una moglie è pesante da sopportare , ma può esserti utile: se, morendo alla svelta, ti lascia erede di tutto» (T. Moro, Tutti gli Epigrammi, San Paolo 1984, 86). Ma quando Enrico VIII gli chiese di firmare l’Atto di Successione, col quale pretendeva di dichiarare nullo il suo matrimonio con Caterina d’Aragona, Tommaso Moro – fino ad allora amico e confidente del Re – non si marcò dalla sua gravissima responsabilità scherzando sulla morte della regina per stemperare la tensione o strappare una risata al sovrano ma si oppose con fermezza sapendo che quell’Atto era per lui «come una spada a due tagli: se si risponde in un modo si rischia la morte dell’anima, se si risponde nell’altro, quella del corpo».
Non un buffone dunque, non un comico, ma un uomo che ebbe ben chiare le priorità e seppe distinguere sapientemente il tempo per piangere dal tempo per ridere (cfr. Qo 3,4). Sapeva che attraverso l’ironia poteva dire grandi verità, per questo la utilizzò per deridere uomini di potere (anche ecclesiastici) e denunciare ingiustizie. Ma sempre con lo scopo di difendere la verità, non certo quello di strappare applausi o approvazione, guadagni o prestigio personale.
Particolarmente accesa fu la sua polemica contro le eresie che si andavano diffondendo in tutta Europa. Con numerosi scritti a lui commissionati confutò gli errori di Lutero, Tyndale, Barnes, Fish e altri riformatori. Così Moro dimostrò la sua grande abilità letteraria (una prosa poetica serrata e incalzante arricchita di arguzia e ironia) ma anche le sue profonde conoscenze teologiche e la fermezza nel voler ristabilite le verità della dottrina tradizionale fondandole nella Sacra Scrittura.
Moro difese caparbiamente l’unità della Chiesa cattolica con fermezza sia opponendosi duramente ai protestanti, sia rifiutando la rottura con Roma a costo di ottenere l’accusa di alto tradimento.
Uomo di vasta cultura e amante delle lettere, ma anche di profonda pietà e devozione, fedele nella pratica della preghiera e dei sacramenti, Moro portava segretamente, nascosto sotto i vestiti, un cilicio; una mortificazione che tenne nascosta persino alla moglie, rivelandola solamente all’amata figlia Margaret.
Uomo con un profondo senso della giustizia, che esercitò nella sua professione di giudice con imparzialità e fermezza ma anche con profonda carità verso i deboli, rifiutando ogni sorta di compromesso col potere.
Lontano da ogni relativismo, la sua fede lo portò a mettere al primo posto la verità rivelata da Dio nella coscienza. Per questo profondo insegnamento, firmato col sangue, Tommaso Moro fu (ed è ancora oggi) fonte di ispirazione per tanti uomini di buona volontà. A lui si accostano le figure di san John Henry Newman e di Gilbert Keith Chesterton, compatrioti che hanno condiviso con Moro la passione per la verità, l’amore alla Chiesa e quella carità intellettuale che fa oggi di loro dei fari nel buio di un relativismo – filosofico, teologico e morale – dilagante. A lui fu molto legato anche papa Benedetto XVI che dedicò a Moro parole di grande stima e profonda riconoscenza, raccolte nel volume Elogio della coscienza. La verità interroga il cuore (Cantagalli 2009).
Di certo san Tommaso Moro insegna molto di più che l’arte di “far ridere”. In un era caratterizzata dal gioco, dal riso e dalla festa, in cui l’homo festivus di cui parlava Philippe Muray, cerca godimento ed evasione in un “impero del Bene” dominato dai buoni sentimenti, sono molti gli insegnamenti che potrebbero trarre da lui gli umoristi e i comici dei nostri giorni dall’esempio del santo inglese.
È vero che, con parole di Chesteron, «la serietà non è una virtù» ed è vero anche che Moro ci insegna a scherzare ridere al momento opportuno. Ma il primato di Dio e della coscienza, l’amore per la Chiesa e per la sua unità, la fedeltà al Papa, il primato della famiglia, l’apertura alla vita, l’esercizio delle virtù (in particolare della carità e della giustizia), l’amore alla tradizione e alla dottrina, fanno di lui un esempio vivo da riscoprire in un mondo che ha perso la bussola e dimenticato Dio per farsi dio di se stesso. Insegnamenti urgenti non solo per i comici ma anche per i cristiani di oggi (inclusi uomini di Chiesa) che rischiano di morire dal ridere, tra grasse risate, dimenticando la loro fondamentale missione: quella della salvezza delle anime.